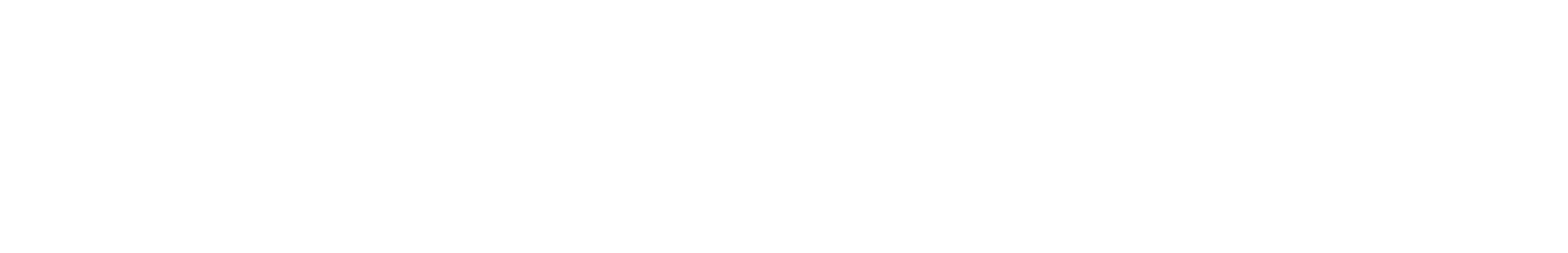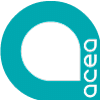Dialogo con George Saunders
di Paolo Cairoli
L’intervista è pubblicata integralmente da Calibano #7 – the turn of the screw/dove abita la paura
Se si pensa alla paura e all’horror nella letteratura americana contemporanea, il primo nome che viene in mente non è certo quello di George Saunders. Eppure, pochi come questo scrittore di racconti – la cui unica incursione nel romanzo ha vinto il Booker Prize nel 2017 e si intitola Lincoln nel Bardo (in Italia tradotto come tutti i suoi libri da Cristiana Mennella per Feltrinelli) – hanno saputo raccontare la nostra realtà di abitanti del capitalismo digitale, spostandola in un altrove appena deformato e molto inquietante, che funge da monito per un futuro più che imminente. Nei racconti usciti quest’anno sotto il titolo Giorno della liberazione si alternano sulla scena pupazzi programmati per il divertimento del loro ideatore, uomini e donne cui è stata sradicata ogni attività mentale per renderli manipolabili, impiegati di parchi a tema cui è stato assegnato un personaggio storico da rappresentare: insomma, incarnazioni della schiavitù nell’era digitale. Lincoln nel Bardo, invece, è ambientato durante la Guerra civile americana: al centro della narrazione c’è il figlio undicenne di Abraham Lincoln, Willie, che, sepolto in una cripta del cimitero di Oak Hill, viene subito circondato da una folla di spiriti. Saunders ha costruito il romanzo come un montaggio di voci, tutte provenienti da persone che noi diremmo ‘morte’, ma alle quali il buddismo tibetano assegna un periodo di transizione dalla vita passata a quella futura: il Bardo, appunto, da cui il titolo del libro. Tutte le voci che si alternano sulla scena del romanzo vengono da persone la cui coscienza si è separata dal corpo e la cui mente ha acquisito una sua consistenza, che non solo viaggia nello spazio ma può anche penetrare nei corpi di altri o risistemarsi nel proprio. Sono spiriti sofferenti, perché secondo il Libro tibetano dei morti non accettano il distacco dalla loro esistenza terrena.
La Metropolitan Opera House ha commissionato proprio un’opera tratta da Lincoln nel Bardo alla compositrice Missy Mazzoli e al librettista Royce Vavrek, e “Calibano” ha potuto incontrare Saunders e parlare con lui di vita, morte e altre piccolezze.
Tradizionalmente i fantasmi, un po’ come i sogni, si presentano non richiesti, mettendoci in relazione con parti di noi più o meno volontariamente nascoste, e arrivando, a volte, a produrre cambiamenti radicali nelle nostre vite. Siamo noi, vivi, ad avere bisogno di loro. In Lincoln nel Bardo invece sembra vero il contrario: sono i fantasmi, se così possiamo chiamarli, ad avere bisogno di ciò che è rimasto nell’aldiqua. Cosa cercano e cosa non riescono a lasciare?
L’idea che mi sono fatto di quel mondo prevede che i fantasmi sentano, a ragione, di essere stati dimenticati, di non avere più alcun ruolo o valore nel mondo dei viventi. Ho letto da qualche parte che i morti amano il fatto che si espongano le loro foto, che si parli di loro, che li si ricordi. Anche nel libro questo ritorna con forza, in particolare nel modo in cui gli abitanti del Bardo reagiscono alla presenza tra loro di Abraham Lincoln, ancora vivo. Per questi spiriti la vita è stata – letteralmente – la cosa più straordinaria che abbiano mai conosciuto, e l’idea che sia finita è per loro inconcepibile.
Gli spiriti sembrano proprio terrorizzati dalla loro condizione: dal non essere più al mondo. Non riescono nemmeno a darle un nome. Viene da pensare che la morte faccia paura anche da morti. Cosa intendeva suggerire con questo?
Direi una forma estrema di negazione. Per alcune persone l’idea della morte è semplicemente insostenibile: sentono di avere ancora compiti da svolgere, errori da riparare. L’idea di essere ormai fuori gioco per sempre blocca gli abitanti del Bardo, li spinge a reinterpretare la propria condizione: dicono di essere malati, di dover aspettare, e così via. Nel profondo restano convinti che, prima o poi, avranno una nuova occasione per tornare alla vita e sistemare le cose.
Oltre che dalla paura, il rapporto tra vivi e morti sembra essere dominato dalla frustrazione. Gli uni cercano gli altri senza una reale possibilità di contatto reciproco.
Era una delle domande centrali poste dal libro: in questo mondo (immaginario) è possibile un vero contatto tra vivi e morti? All’inizio pare di no. Poi arriva Lincoln, che ama profondamente il figlio morto, e le speranze si riaccendono. I fantasmi cercano di ‘abitare’ Lincoln, ma sembrano non ottenere nulla; così tornano al loro iniziale sconforto. Ma poi – almeno nella mia interpretazione del libro – vediamo l’ex schiavo Thomas Havens entrare nel corpo di Lincoln con l’intento di trasmettergli la sofferenza del popolo nero in America. Si noti che Lincoln, in effetti, è stato trasformato dalla tristezza collettiva di tutti quegli spiriti. E sappiamo dalla Storia che non molto tempo dopo quella notte Lincoln firmò il Proclama di Emancipazione, liberando gli schiavi. Quindi, almeno in questo universo fittizio, i rapporti di causa-effetto sembrerebbero sostenere che ci fu effettivamente un contatto reciproco tra i morti e i vivi.
Tutti i personaggi, vivi e morti, sembrano mossi da una forma di egoismo che alimenta la loro frustrazione. Ognuno è concentrato su ciò che desidera ancora. Lincoln vuole stringere di nuovo a sé il figlio, mentre il bambino si agita nel tentativo di mostrarsi nella sua nuova condizione. Come ha pensato questa tensione?
Ho immaginato questi desideri come forme di ‘energia potenziale’, per usare un termine della fisica. L’amore di Lincoln si trasforma in lutto, e questo lo spinge a cercare ogni modo possibile per ‘avere di nuovo’ suo figlio. Willie, che aveva di fronte a sé una vita intera, si rifiuta di lasciare il Bardo. È come se una persona si appoggiasse con forza a un muro, e improvvisamente quel muro sparisse: l’energia resta, e lo fa crollare a terra.
Nelle ultime pagine Lincoln sembra aggrapparsi ai propri doveri, quasi cercando una via di salvezza: ha tanto da fare, e questo pare aiutarlo a sopravvivere alla perdita. Lei si è mai chiesto se la nostra mente possa davvero superare lo ‘scandalo’ della morte di un figlio?
Credo di no, non del tutto. Scrivendo, mi è venuto da pensare che amore e lutto siano due facce della stessa medaglia. Più ami, più soffri – più forte è la spinta, più dolorosa è la caduta. Lincoln riesce a tornare all’azione attraverso il ragionamento: capisce che il corpo del figlio non è il figlio, non più; e che attaccarsi alla materia è un’illusione. Una cosa che ho scoperto su Lincoln, studiandolo, è che era un uomo molto razionale, quasi sillogistico nei suoi pensieri. Questo modo di ragionare lo aiuta a uscire dalla cripta, e, poco dopo, Willie (anche lui ragionando in modo logico, sulla base della sua ‘revisione’ dei ricordi del padre) lascia il corpo di Lincoln, e questi viene definitivamente liberato e può tornare ai suoi compiti. È un percorso graduale nel quale padre e figlio collaborano per una verità comune.
Lincoln nel Bardo diventerà un’opera lirica della compositrice Missy Mazzoli: la prima assoluta è in programma nell’autunno del 2026 al Metropolitan di New York. Lei che rapporto ha con questa forma d’arte: pensa possa aggiungere qualcosa alla dimensione letteraria?
Amo profondamente l’Opera e in effetti, mentre scrivevo il libro, lo immaginavo quasi come un’opera lirica – pochi scenari, tante voci, forti contrasti emotivi. Sono felicissimo del progetto, e non potrei immaginare una compositrice migliore di Missy. La sua musica è ricca di sfumature: lirica, tagliente, ironica a tratti. Quando ci siamo incontrati a New York, ho avuto l’impressione di parlare con una parte di me: condividevamo la stessa visione del progetto. C’è stata un’intesa immediata.
In un’altra opera, The listeners, Missy Mazzoli ha saputo evocare magistralmente un suono che solo la protagonista e pochi altri possono sentire: un suono carico di alterità e straniamento. Lei ha mai pensato, scrivendo il libro, che il Bardo avesse una dimensione sonora e acustica diversa dal mondo reale?
Non particolarmente, perché non ho una fantasia musicale molto sviluppata. Per me collaborare significa trovare la persona giusta: appassionata, libera, con un rapporto profondo con il libro e lasciarle spazio. Preferisco affidare l’opera a chi ha un vero talento, piuttosto che imporre idee mie poco fondate.
Quali difficoltà potrebbe incontrare un adattamento teatrale del romanzo?
La difficoltà principale è che il libro contiene moltissime narrazioni – anche tratte da fonti storiche. Ma il librettista, Royce Vavrek, è riuscito a estrarre con grande sensibilità il nucleo drammatico del testo, rendendo il libretto rapido, emozionante, essenziale.
Il libro Giorno della liberazione descrive una società dominata dal controllo, dall’intrattenimento mercificato, dall’illusione e dalla sorveglianza. Un universo inquietante, eppure non così distante dal nostro presente. Come sono nate queste storie, e dove sta andando il nostro mondo, secondo lei?
Non credo molto all’ispirazione in senso classico. Il mio metodo è semplice: cerco di vivere con una certa apertura al mondo e con curiosità, senza giudicare troppo, confidando nel fatto che tutto verrà a galla nel momento della scrittura. Scrivo, riscrivo, perfeziono: è un modo per permettere all’inconscio di affiorare. Spesso è solo alla fine che capisco cosa penso davvero. Quindi: più esplorazione, meno predicazione. Detto questo, è stato colto il punto: il modo in cui comunichiamo ci sta cambiando, e diventiamo più materialisti nel pensare e nel sentire; più letterali e meno aperti, più giudicanti e meno amorevoli. È un effetto inevitabile del continuo flusso di contenuti che sono, in fondo, forme di propaganda: a favore delle grandi aziende, contro l’ambiguità, pensate per trasformarci in tribù, in ragione del profitto. Non ci sono menti diaboliche a monte, è il sistema stesso che lo vuole, e noi siamo troppo condizionati – di nuovo, a causa del nostro modo materialistico di pensare – per opporci efficacemente.
Il nostro intrattenimento, ormai digitalizzato, è diventato lo spazio principale del controllo. Nei suoi racconti è spesso il riaffiorare improvviso di una vita dimenticata a offrire una possibilità di redenzione. È una forma di nostalgia per un’esistenza diversa?
Più che nostalgia, si tratta, credo, di un incontro con il reale. Vedi un prato sullo schermo gigante… poi ti stendi davvero su un prato. Entrambe sono esperienze legittime, ma la seconda coinvolge tutto il corpo, e per me è ‘migliore’. I miei personaggi vivono immersi in una realtà filtrata, costruita per qualcun altro, ma a volte riaffiora il ricordo di quando erano semplicemente loro stessi, nel mondo vero. E allora il racconto chiede: quale delle due vite preferisci? Sei disposto a fare ciò che serve per tornare là? Una frase che mi accompagna spesso suona così: “relazione autentica”. Oggi, siamo costantemente interpellati da voci lontane – un podcast, una pubblicità, un telegiornale – o l’intervista di uno scrittore, ehm. Nulla di sbagliato in sé, ma dovremmo interrogarci sul nostro senso delle proporzioni: cosa accade alla mente e al cuore se a parlarci è sempre qualcuno di distante, con motivazioni poco chiare? Forse il nostro compito, come persone di oggi, è imparare a distinguere, scegliere, dosare gli impulsi primari e quelli mediati: per restare sani, meno irritabili, e più capaci di amare.
George Saunders (1958, Amarillo, Texas) è uno scrittore statunitense. Ha pubblicato racconti, saggi e un romanzo, vincendo nel 2017 il Booker Prize con Lincoln nel Bardo. Collabora regolarmente con il «New Yorker» e insegna scrittura creativa alla Syracuse University. Nel 2025 ha vinto il National Book Award.
Calibano – L’opera e il mondo è la rivista del Teatro dell’Opera di Roma. Nata come spazio di approfondimento e di dibattito intorno a temi di attualità sollevati a partire dagli spettacoli in cartellone e realizzata in collaborazione con la casa editrice effequ, il progetto editoriale prevede, ogni quattro mesi, la pubblicazione e la diffusione nelle librerie italiane di un volume monografico dedicato a un titolo d’opera e a un tema ad esso collegato, attraverso la commissione di saggi, racconti e recensioni di firme autorevoli. In questo settimo numero, la rivista riflette sulla paura e sul sentimento orrorifico a partire da The turn of the screw di Benjamin Britten.
Potete acquistare “Calibano” sul sito di effequ a questo link, in libreria e presso lo shop del Teatro dell’Opera di Roma.
Le illustrazioni interne di questo numero e la copertina sono di Oona Ode.