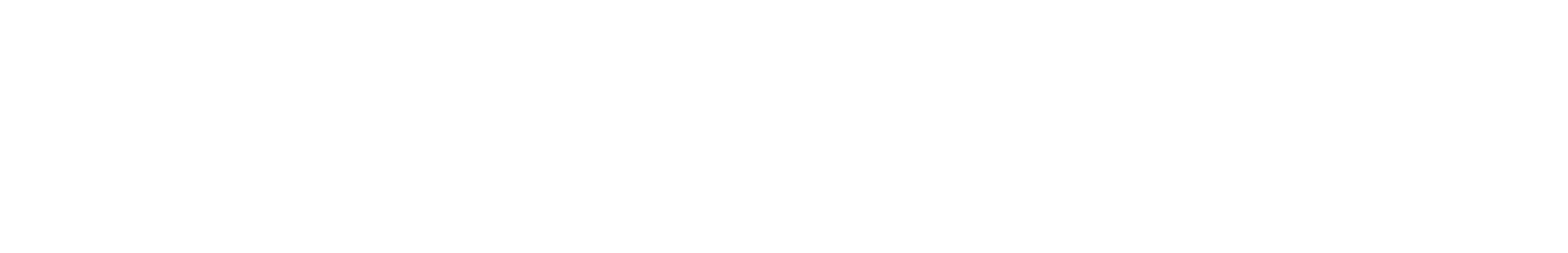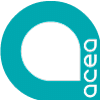Persecuzione, possessione e ripetizione nell’industria culturale
di David Bering-Porter
traduzione di Valentina Rapetti
Il seguente saggio è pubblicato integralmente da Calibano #7 – the turn of the screw/dove abita la paura
Tutti siamo perseguitati dal passato, ma ne siamo anche posseduti? E qual è la differenza tra persecuzione e possessione? L’uscita de L’esorcista nel 1973 fu accolta da una delle reazioni più estreme della storia del cinema. Le cronache dell’epoca narrano di spettatori e spettatrici che vomitavano nei corridoi, che svenivano e fuggivano dalle sale in preda al terrore per le immagini proiettate sullo schermo. Alcuni gestori riferirono di aver piazzato delle ambulanze fuori dai cinema con medici pronti ad assistere il pubblico sovraeccitato. Si tratta senza dubbio di esagerazioni sensazionalistiche create a scopo pubblicitario (purché se ne parli, recita un noto adagio), un susseguirsi di voci inarrestabili che precedevano le proiezioni come un rombo di tuono, accrescendo il valore semiotico del film ed estendendone la portata. L’esorcista è stato un vero e proprio evento nella cultura americana e la fama che lo precedeva serviva a stimolare la curiosità di un pubblico potenziale, impaziente di vedere di cosa si trattasse e di mettersi alla prova con il suo potere orrorifico. Sono pochi i titoli che vantano una fama più negativa de L’esorcista, che oltre al pubblico in sala è riuscito a terrorizzare anche chi non l’aveva visto. Nella sua analisi del film, Mark Kermode afferma che “per la prima volta in una produzione destinata al grande pubblico si assisteva alla profanazione brutale di quanto di sano e buono ci fosse nel mito, già in crisi, del sogno americano: la casa, la famiglia, la chiesa e, cosa ancor più scioccante, l’infanzia” (The Exorcist, BFI Institute/ Bloomsbury Publishing, London and New York, 2003). Eppure, continua Kermode, “i rimedi che L’esorcista sembrava proporre a chi auspicava un ritorno a un ordine morale assoluto erano stranamente rassicuranti”. Secondo lo studioso, L’esorcista è una sorta di fantasia o di desiderio esaudito, un dispositivo che alimenta la nostalgia per le certezze del passato e per una visione del mondo intrinsecamente e strutturalmente conservatrice. Nel film, il rapporto tra il femminile, il maschile e il paranormale suggerisce chiaramente un’inclinazione verso valori tradizionali e l’orrore è generato dal desiderio delle solide certezze del passato e di una politica della riconoscibilità e del ritorno.
E non è questo, forse, il desiderio segreto che si cela nel fondo del genere horror? Tornare all’innocenza o a uno stato di grazia perduti, sentirsi ancora una volta sicuri come da bambini, in un mondo che da adulti sappiamo essere privo di sicurezze e di risposte facili alle domande complesse e ai dubbi che ci poniamo? Il mio intento qui non è tanto quello di celebrare L’esorcista in quanto emblema del genere horror, bensì di analizzarlo come sintomo di un fenomeno che anima l’horror stesso, e forse perfino dell’orrore che si cela in molte altre forme di produzione culturale e che ci rende tutti prede del passato, un passato che non ci lascia andare. Le prove sono ovunque, tutt’attorno a noi, e circolano nel discorso sui media e sull’industria cinematografica che deplora la piaga delle repliche proiettate continuamente sui nostri schermi sotto forma di sequel o prequel, di remake, reboot e revival. Da L’esorcista, ad esempio, sono stati tratti tre sequel, diversi spinoff e una serie televisiva, senza considerare le decine di imitazioni ufficiose. I film che raccontavano storie di possessione erano piuttosto rari prima de L’esorcista, mentre ora l’industria cinematografica pullula di corpi posseduti e di case infestate. Si potrebbe quasi dire che Hollywood è infestata dai fantasmi del passato e che è posseduta dallo spettro della proprietà intellettuale, la forza trainante di molta produzione culturale contemporanea. Spinti a ripetere incessantemente le stesse storie, basate su quelle che hanno già prodotto e che quindi possiedono, Hollywood e altri avatar dell’industria culturale sono finiti preda della piaga delle repliche e la ripetizione, a quanto pare, è l’imperativo che regola il loro modus operandi.
Si ritorna dunque alla domanda iniziale: tutti siamo perseguitati dal passato, ma ne siamo anche posseduti? E c’è una differenza tra persecuzione e possessione? L’orrore generato dalla persecuzione deriva da qualcosa che persiste: un’entità, un discorso o un evento che permane ostinatamente nel presente anche dopo che il suo tempo è finito. Essere perseguitati da qualcosa significa che il passato e il presente si confondono, che il passato si rifiuta di finire e continua ad affermarsi nel presente indipendentemente dalle conseguenze. In quasi tutte le culture esiste una forma d’apprensione legata ai morti che ritornano, che si rifiutano di morire e si presentano nelle case e nelle vite dei vivi come ospiti indesiderati. Già nell’antica Mesopotamia si praticavano incantesimi e rituali per evitare che i defunti si presentassero a cena o che si avvicinassero ai dormienti sussurrando loro nell’orecchio, il più vulnerabile degli orifizi cefalici. Per gli umani i fantasmi sono l’emblema della persecuzione; nel nostro immaginario antropocentrico, l’aspetto del fenomeno a cui prestiamo maggiore attenzione è quello che ci somiglia di più. In Ghostly Matters (University of Minnesota Press, 1997), il sociologo Avery Gordon scrive che “se la persecuzione assume le sembianze di ciò che non dovrebbe esistere, e che tuttavia si rivela una presenza tangibile che agisce e spesso si intromette in realtà note, il fantasma non è altro che un segno, un’evidenza empirica che ci conferma che è in atto una persecuzione”. Le parole di Gordon ci aiutano a pensare alla persecuzione in termini spaziali; anziché focalizzarsi sul fantasma come causa primaria del fenomeno, Gordon suggerisce che la persecuzione potrebbe essere compresa meglio se si indagassero le condizioni strutturali che la rendono possibile. Nell’evidenziare la connotazione spaziale e schematica della persecuzione, Gordon la rende uno strumento analitico utile a comprendere il contesto sociale e culturale nel quale avviene.
Le storie di fantasmi confermano la sua ipotesi. Un esempio eloquente è il racconto gotico di Henry James Il giro di vite, in cui un’istitutrice si reca in una tenuta di campagna per prendersi cura di due bambini e scopre che la dimora è infestata dai fantasmi di due servitori defunti. Proprio come suggerisce Gordon, queste presenze spettrali indicano una situazione più complessa e problematica. Il fantasma del maggiordomo sembra particolarmente attratto dal bambino e dunque la narrazione stessa appare infestata dallo spettro di un abuso sessuale. Il racconto di James verte sull’ambiguità della narrazione: non si capisce se i fantasmi siano reali o se siano la proiezione di un narratore inaffidabile. Tuttavia, lo spettro dell’abuso e della sessualizzazione del bambino riappare negli adattamenti successivi e in particolare in quello operistico di Benjamin Britten, in cui i fantasmi sono presenze più concrete, reali, che danno corpo a un desiderio illeci to e pericoloso manifestato nell’ossessione spettrale; una scelta particolarmente inquietante alla luce della sospetta pedofilia di Britten.
Come osserva Philip Brett, nell’opera di Britten “il contesto rimanda al discorso ottocentesco sulla sessualità e ci aiuta a capire che la perse cuzione narrata nella storia ha uno scopo sessuale” (“Male Relations in The Turn of the Screw” in Music and Sexuality in Britten: Selected Essays, University of California Press, 2006). La sessualità è lo scopo sotteso alla maggior parte delle cose, direbbe Sigmund Freud, eppure in questa tipica storia di bambini perseguitati l’ossessione sessuale di Britten per gli adolescenti rivela un insieme di segreti e di presenze inquietanti. L’ipotesi di Brett è che, come spesso accade nei soggetti traumatizzati, potrebbe esserci una coazione a ripetere, una dinamica che in effetti ricorre in diversi adattamenti de Il giro di vite. Eppure, questa lettura non sembra soddisfacente: senz’altro spiega uno dei modi in cui il passato può tornare traumaticamente nel presente, ma tralascia un aspetto rilevante che vorrei indagare attraverso un’analisi dell’orrore come possessione anziché persecuzione. Se la persecuzione si manifesta in uno spazio in cui il passato si riaffaccia sotto forma di fantasma o di altra presenza spettrale, la possessione avviene all’interno del soggetto anziché al suo esterno. Una casa può essere infestata e i suoi abitanti perseguitati da entità sovrannaturali, ma a essere posseduto è il sé. La persecuzione ha luogo al di fuori dei confini dell’individuo, mentre la possessione avviene al suo interno. È una sorta di chiamata interiore. È questo, forse, uno dei motivi per cui L’esorcista è così terrificante. Nel caso della possessione, la minaccia non viene dall’esterno, ma è l’Io stesso a rivelarsi aperto e poroso, permeato dall’esterno e dall’altro. In effetti, la possessione non riguarda semplicemente la permeabilità del sé e la possibilità che un’entità esterna penetri nei suoi recessi più intimi, bensì il coinvolgimento attivo della nostra interiorità.
Ne Il giro di vite, i fantasmi che infestano la dimora perseguitano i bambini che vi abitano per esercitare su di loro una forma di corruzione, sessuale o di altro tipo, mentre ne L’esorcista Reagan, la bambina posseduta, è già intimamente predisposta alla corruzione. Nel suo libro semiautobiografico sul film (Night Mother: A Personal and Cultural History of The Exorcist, Columbus, 2023) Marlena Williams afferma che l’orrore è generato in larga misura da ciò che sentiamo anziché da ciò che vediamo. Scrive Williams:
All’apice della possessione, dalla bocca di Reagan fuoriescono rantoli bronchiali e gemiti gutturali… la sua voce, simile a quella di un animale moribondo che tenta di uscire da una gola escoriata dal fumo aggrappandovisi con gli artigli, non è la voce di una bambina innocente.
Che non sia una bambina innocente lo attestano il turpiloquio blasfemo e la celebre battuta “Tua madre succhia cazzi all’inferno!”, forse la più famosa del film. Qui non sono solo le parole a essere fuori luogo, ma soprattutto la voce del demone Pazuzu prestata dall’attrice Mercedes McCambridge, notevolmente più adulta di Linda Blair, la giovane interprete che vestiva i panni di Reagan. Lo studioso Mladen Dolar definisce questo inquietante scollamento tra voce e corpo “voce acusmatica”(A Voice and Nothing more, Cambridge and London, The MIT Press, 2006), una voce separata dalla sua fonte visibile che evoca qualcosa di sovrannaturale o ultraterreno. Ne L’esorcista la voce demoniaca funziona proprio perché rivela la capacità della voce stessa di mettere in crisi la nostra idea di soggettività univoca e di integrità corporea. Questa voce estranea, emanata dal corpo di una bambina, è indice di un’alterità in grado di penetrare nel sé e costituisce una minaccia alla nozione omogenea di identità su cui si fondano le nostre concezioni sociali, storiche e legali di responsabilità, libero arbitrio e proprietà. Più indietro abbiamo ipotizzato che tanto il genere horror quanto l’industria cinematografica siano in un certo senso possedute dalla proprietà intellettuale, un dispositivo giuridico che costringe l’uno e l’altra a replicare incessantemente le stesse idee, le stesse storie, lo stesso stile, giustificandosi con l’alibi dell’imperativo economico di “dare alla gente quello che vuole”. Eppure, a quanto pare il pubblico è stufo di vedere prodotti in serie che propongono l’ennesima iterazione della stessa vecchia storia. La mera argomentazione economica non è sufficiente a spiegare il fenomeno, per questo una riflessione più articolata sul genere horror può aiutare a comprendere che si tratta di un problema culturale più ampio. Forse, il vero orrore suscitato dalla possessione non sta nell’occupazione del sé da parte di un altro – per quanto inquietante possa essere – ma nella nozione di proprietà.
Se, come suggerisce Gordon, la persecuzione è un paradigma analitico utile a comprendere le condizioni che rendono possibili determinati contesti storici e sociali, allora anche la possessione può essere impiegata come strumento d’indagine per apprendere qualcosa di importante sulla soggettività. Affermare che Hollywood è posseduta dalla sua stessa proprietà intellettuale equivale a dire che è posseduta dai suoi stessi beni, ed è nella duplice accezione del possesso – come occupazione e come proprietà – che questa ipotesi appare fondata.
Se spostiamo il fuoco analitico dal posseduto al possessore, diventa chiaro che possedere una creatura – o una creazione – significa considerarla un oggetto, una cosa, e ridurre la complessità della sua esistenza a una parvenza di vita, per giunta posta al servizio di un altro. L’atto del possesso implica rendere qualcosa una proprietà, e se l’oggetto posseduto è una creatura vivente il possesso costituisce una tra le forme peggiori di oggettivazione. La possessione mina la sacralità dell’individuo, dimostra che non siamo necessariamente padroni di noi stessi e che dentro di noi possono trovare spazio moltitudini. Persino il termine ‘individuo’, che rimanda a un carattere di unicità e indissolubilità, sembra dissolversi se investito dalla possessione, un fenomeno che sgretola la sovranità dell’Io. Non sorprende, dunque, che un’entità industriale possa cadere preda della possessione nelle varie accezioni del termine.
La possessione, quindi, non è un mero fenomeno sovrannaturale, ma uno strumento che ci aiuta a riflettere profondamente sulla natura del libero arbitrio, della proprietà e del sé nel sistema capitalista. Quando assistiamo alla ripetizione compulsiva di prodotti in serie da parte di Hollywood, vediamo un’industria posseduta dalla sua stessa proprietà intellettuale, intrappolata in un ciclo infinito di riproduzione delle stesse narrazioni non per necessità creativa, ma a causa degli imperativi strutturali che derivano dal dispositivo legale della proprietà. Questa forma di possessione, in cui le produzioni culturali del passato continuano ad animare il lavoro creativo presente, riducendo la vitalità dell’espressione artistica alla riproduzione meccanica di formule redditizie, ricorda il lavoro forzato dei morti viventi tipico del genere horror.
Ecco allora che la differenza tra persecuzione e possessione risulta cruciale: mentre la prima può concludersi con un esorcismo, e dunque con la possibilità di mettere a tacere il passato, la seconda implica un’occupazione più totalizzante, in cui i confini tra possessore e posseduto diventano sempre meno definiti. Il fatto che Hollywood sia posseduta dalla sua stessa proprietà intellettuale è emblematico di una più ampia condizione culturale del tardo capitalismo, in cui gli individui si ritrovano posseduti dalle cose che credono di possedere, siano esse beni materiali, narrazioni culturali o sistemi ideologici.
In questo senso, il vero orrore de L’esorcista e più in generale dei film di possessione non sta tanto nel loro mostrare la violazione sovrannaturale dell’integrità corporea, quanto nel modo in cui espongono la natura irrimediabilmente compromessa della sovranità dell’Io. La bambina posseduta diventa l’emblema di una possessione culturale più ampia, che ci vede tutti coinvolti.
La voce che parla attraverso Reagan, quella voce acusmatica dell’altro, ci dice che non siamo mai pienamente padroni di noi stessi e che la nostra interiorità è sempre occupata da forze che sfuggono al nostro controllo. Forse il vero esorcismo di cui abbiamo bisogno non è quello dai demoni, ma dalla logica possessiva insita nel concetto di proprietà.
David Bering-Porter è Assistant Professor di Cultura e Media all’università The New School di New York. I suoi interessi di ricerca uniscono la teoria dei media digitali, i media studies e le intersezioni tra razza ed economia politica. Il suo libro Undead Labor: Capitalist Fantasies and the Uncanny Vitality of the Zombie è in corso di pubblicazione con la University of Minnesota Press. Suoi scritti sono apparsi in riviste come «Critical Inquiry», «MIRAJ», «Culture Machine» e «Los Angeles Review of Books».
Calibano – L’opera e il mondo è la rivista del Teatro dell’Opera di Roma. Nata come spazio di approfondimento e di dibattito intorno a temi di attualità sollevati a partire dagli spettacoli in cartellone e realizzata in collaborazione con la casa editrice effequ, il progetto editoriale prevede, ogni quattro mesi, la pubblicazione e la diffusione nelle librerie italiane di un volume monografico dedicato a un titolo d’opera e a un tema ad esso collegato, attraverso la commissione di saggi, racconti e recensioni di firme autorevoli. In questo settimo numero, la rivista riflette sulla paura e sul sentimento orrorifico a partire da The turn of the screw di Benjamin Britten.
Potete acquistare “Calibano” sul sito di effequ a questo link, in libreria e presso lo shop del Teatro dell’Opera di Roma.
Le illustrazioni interne di questo numero e la copertina sono di Oona Ode.